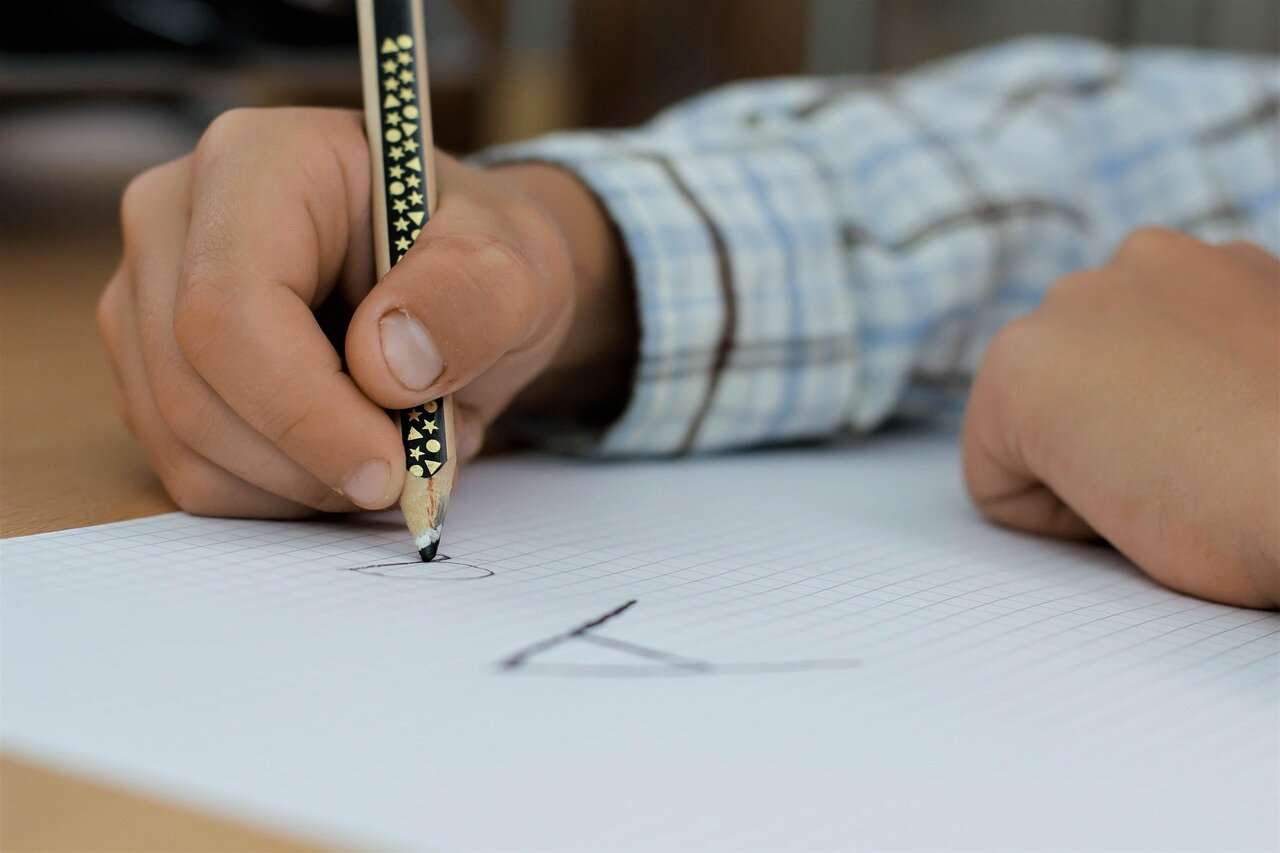Nei bambini che oggi frequentano la scuola dell'infanzia, quindi nella fascia tra i tre e i sei anni, stiamo osservando caratteristiche evolutive che non possono essere comprese pienamente senza considerare l’impatto della pandemia da COVID-19, avvenuta in un periodo cruciale per il loro sviluppo.
La pandemia ha avuto il suo periodo più intenso tra il 2020 e il 2021, ma le ripercussioni sulla vita quotidiana delle famiglie e dei servizi educativi sono durate fino al 2022.
I bambini nati tra il 2019 e il 2022 hanno vissuto i primissimi mesi e anni di vita in un contesto completamente diverso da quello delle generazioni precedenti, un contesto fatto di distanziamento sociale, riduzione delle esperienze esterne, instabilità organizzativa e forte stress genitoriale.
Questo non significa che la pandemia abbia lasciato “traumi” in senso stretto, ma sicuramente ha modificato l’ambiente di crescita. Quando cambia l’ambiente, cambiano inevitabilmente anche le opportunità di sviluppo.
È proprio in questa cornice che si collocano molte delle osservazioni che oggi fanno educatori, insegnanti, psicologi e famiglie.
I primi anni di vita rappresentano una finestra estremamente sensibile, in cui il cervello dei bambini cresce e si organizza attraverso l’esperienza quotidiana: volti, interazioni, movimenti, routine, contatti con i pari, esplorazioni dell’ambiente.
La pandemia ha interrotto o ridotto molte di queste esperienze.
Durante il 2020 e il 2021 i servizi educativi hanno vissuto chiusure improvvise, quarantene ripetute, cambi di personale, protocolli rigidi. I nidi hanno avuto una presenza altalenante, i parchi pubblici sono stati chiusi per settimane, le attività di gioco libero e di gruppo sono state fortemente limitate.
Molti bambini hanno passato lunghi periodi in casa con poche figure di riferimento, spesso solo i genitori, che a loro volta vivevano un alto livello di stress e preoccupazione.
Questa combinazione ha creato, senza colpa di nessuno, un ambiente più povero dal punto di vista sociale e comunicativo, una sorta di “microcosmo domestico” in cui il bambino ha avuto meno occasioni di mettersi alla prova.
Il primo elemento che emerge è la riduzione della stimolazione sociale: nei primi mesi di vita i neonati hanno visto poche persone, spesso sempre le stesse, e quelle persone erano spesso parzialmente coperte da mascherine, che limitavano la lettura del volto, l’imitazione dei movimenti della bocca, l’osservazione dei segnali emotivi.
Le competenze socio-comunicative si costruiscono anche attraverso l’esposizione alla varietà dei volti, dei toni di voce, delle espressioni.
Molti professionisti dei servizi 0–6 riportano oggi una maggiore frequenza di bambini che faticano a leggere le emozioni altrui, a gestire la frustrazione nelle interazioni con i pari e a esercitare alcune competenze sociali tipiche della materna, come aspettare il turno o negoziare il possesso di un gioco.
A questo si aggiunge la riduzione del gioco tra pari nei primi due anni di vita, un aspetto che più di tutti plasma la capacità di regolare emozioni e comportamenti. Il gioco con altri bambini è una palestra naturale: insegna a condividere, a litigare e fare pace, a usare il corpo in movimento, a inserirsi in dinamiche di gruppo. La mancanza di questa palestra nei primi mesi, unita a un rientro nei servizi segnato da quarantene continue, ha prodotto un ingresso alla materna più difficile per molti, con più crisi emotive, più difficoltà a separarsi dai genitori e un bisogno maggiore di contenimento da parte degli adulti.
Un altro aspetto riguarda il linguaggio. Numerosi servizi italiani di logopedia e neuropsicomotricità hanno osservato un aumento significativo dei ritardi linguistici espressivi nei bambini nati durante la pandemia.
Questo non significa che la pandemia “abbia causato" ritardi, ma che aumenti sicuramente alcuni fattori di rischio: meno interazioni con adulti esterni, meno scambi comunicativi, meno stimolazione varia, più tempo passato davanti agli schermi perché i genitori erano impegnati con lo smart working o con la gestione domestica in condizioni difficili.
Il linguaggio si nutre di dialoghi, letture, imitazioni, giochi sonori e scambi spontanei: l’ambiente chiuso e ripetitivo del periodo pandemico ha ridotto ognuna di queste dimensioni.
Molte famiglie hanno introdotto o aumentato l’uso dei dispositivi digitali nei primi due anni di vita dei figli, per necessità più che per scelta. Anche questo ha un effetto su attenzione, autoregolazione e sviluppo comunicativo, perché sostituisce una parte del tempo che normalmente sarebbe dedicato all’interazione reale.
Altro elemento rilevante è la relazione di attaccamento e la gestione della separazione. I bambini nati in questi anni hanno sperimentato pochi distacchi graduali: niente nonni per mesi, nessuna babysitter, nessun nido o frequenza saltuaria, pochissime uscite. Molti genitori hanno passato lunghi periodi con i bambini senza pause, spesso vivendo essi stessi ansia, incertezza economica, isolamento sociale. Questo ha portato a legami molto stretti – spesso intensi e positivi – ma che rendono più difficile tollerare le separazioni all’ingresso alla scuola materna.
Gli insegnanti segnalano infatti un aumento di ansia da separazione, regressioni, pianto prolungato e fatica nell’adattamento, fenomeni coerenti con una storia di pochi distacchi e con un ambiente domestico molto contenitivo.
Si notano ancora ritardi nelle autonomie personali: bambini che faticano a vestirsi, a mangiare da soli, a usare regolarmente il bagno, a regolare i ritmi sonno–veglia. Anche questo è comprensibile, perché la pandemia ha reso le routine domestiche più flessibili e meno strutturate, e i genitori, oberati da mille richieste, hanno spesso fatto al posto dei bambini per praticità.
Nel complesso, ciò che osserviamo nella fascia 3–6 anni di oggi non va letto come una “generazione problematica” ma come la conseguenza naturale di un ambiente di crescita anomalo: meno relazioni, meno movimento, meno alternanza tra casa e mondo esterno, più stress familiare, più schermi, più instabilità nei servizi educativi. Non sono bambini fragili, né segnati, ma bambini che hanno avuto un inizio di vita fuori dalla norma e che necessitano di contesti educativi capaci di accompagnare il recupero: più gioco libero, più relazione, più routine prevedibili, più educatori formati sulla regolazione emotiva e sulle difficoltà comunicative.
La pandemia non ha creato “patologie”, ma ha modificato i contesti di sviluppo: è lì che si colloca la relazione tra COVID-19 e i bambini che oggi sono alla scuola materna. Se aiutati con intenzionalità educativa e supporto familiare, i bambini recuperano in modo naturale tutto ciò che è mancato, perché lo sviluppo non è mai statico, ma una danza continua tra bambino, contesto e opportunità.